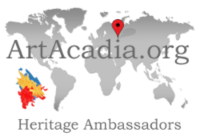L’arte dei graffiti è un movimento di protesta contro l’emarginazione sociale e nasce con i writers, solitamente ragazzi, che appartengono a minoranze etniche e sociali.

Negli anni ’60, nascono le prime bombolette aerosol attraverso le quali, negli Stati Uniti si sviluppa il fenomeno del graffitismo. Con tecnica a spruzzo, spesso ci si riferisce alla street art, ai murales e ai graffiti, cioè interventi artistici realizzati in luoghi pubblici e visibili a tutti.
Il graffitismo è strettamente legato allo studio dei caratteri “lettering“, ed alla ripetizione delle tag, cioè degli pseudonimi degli artisti, che iniziano a comparire ovunque nelle grandi metropoli, soprattutto su mezzi pubblici, così da ottenere maggiore visibilità.
Li troviamo in ogni città e paese, decorano edifici, ponti e spazi pubblici. Tuttavia, nonostante il loro valore artistico, anche i graffiti rappresentano un problema significativo per il Patrimonio storico architettonico. In alcuni luoghi degradati possono essere associati a vandalismo e criminalità, rischi per la salute e la sicurezza pubblica e conseguenze economiche e ambientali per le comunità, ma il tema più scottante è il loro impatto sugli edifici storici architettonici.
In Europa e soprattutto in Italia le città storiche e città d’arte devono la loro bellezza e attrattiva alla loro architettura e ai materiali impiegati per la costruzione: mattoni fatti a mano (Venezia un esempio), marmi (Roma un esempio), pietre rare, facciate affrescate e facciate decorate. Fino ad un altezza di 2 metri, dove la superficie è piana e liscia e monocolore, gli artisti dei graffiti vedono una lavagna ideale per esprimere la propria arte.
Ci chiediamo come mai gli artisti che utilizzano questi “spazi”, non considerino il valore storico del costruito. Queste superfici costituiscono il valore estetico di bellezza e armonia, attraenti per lo sguardo di chi viene da fuori ad ammirare e così importanti per le radici di chi è nato e vive da generazioni in quei luoghi e in quegli spazi.
Diversamente, le superfici di cemento di ponti stradali in città o di costruzioni moderne senza alcuna bellezza o tradizione costruttiva, possono trarre colore e valore artistico dalle opere dei graffitari e trasformare una vista grigia e tetra in un ambiente attraente.
I graffiti sugli edifici storici invece esprimono protesta contro il vecchio ma anche degrado, irriverenza, supponenza, deturpano un assetto urbano che ha un valore anche commerciale come attrattiva turistica e riferimento culturale. Il Patrimonio Storico Architettonico è un bene comune irripetibile per la sua storicità e come tale andrebbe rispettato.
I graffitari agiscono continuamente a colpi di tag e scarabocchi anche sugli edifici di interesse storico e culturale, come nel centro di Bologna: “Non sono opere d’arte e neppure messaggi politici. Sono solo imbrattamenti di cui non riusciamo a liberarci nonostante gli interventi ormai costanti”. A sfogarsi, anche se con tono piuttosto rassegnato, uno dei tanti residenti di via Belle Arti: “Guardi Palazzo Bianconcini (1400) come è stato ridotto! E anche Palazzo Bentivoglio, che stanno ridipingendo proprio in questi giorni: non c’è rispetto per i gioielli della nostra città e per quanto noi cittadini raccolti anche in comitati ci diamo da fare per rimetterli in sesto (con spese e fatica), basta una bomboletta e tutto torna come lo vede adesso. Deturpato”.
Una bella differenza quella che c’è fra le ‘tag’ e gli ‘scarabocchi’ rispetto ai graffiti ‘veri’ come quelli (belli) che hanno recentemente hanno riqualificato il ponte Stalingrado.
Generalmente, i graffitari più vicini ad un lavoro di ricerca artistica tendono a esprimersi in campi più protetti, come nelle “hall of fame”, spazi a disposizione dei graffitari in cui dipingere legalmente (siano questi muri esplicitamente dedicati dalle amministrazioni comunali all’espressione della cosiddetta “arte della bomboletta” (spray-can art) un modo, questo, per cercare di arginare il dilagare del fenomeno nel contesto dei centri storici o di quartieri residenziali – o siano luoghi siti in periferie degradate o di poco interesse o difficilmente raggiungibili in cui, per un tacito accordo con gli organi deputati al controllo dell’ordine pubblico, si lascia ai graffitari “carta bianca” e una relativa tranquillità per dipingere). I graffitari che scelgono di esprimersi per lo più in contesti del genere, attraverso la scelta consapevole e responsabile del supporto per la pittura, si distinguono dai vandali che intervengono anche su edifici di interesse storico e artistico.
I giuristi che si sono occupati di Street Art, nonostante gli sforzi dottrinari di applicare istituti del codice civile alle opere realizzate su edifici di proprietà di altri soggetti, sono risultati inadeguati. Si tratta di ipotesi pensate per fenomeni differenti, in un’altra epoca storica, il codice è del 1942, e rispondono a interessi economici e sociali diversi, essendo legati a ideali produttivistici che non combaciano con quelli che dovrebbero essere alla base della tutela dei beni culturali.

In Italia, il codice penale all’art. 639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui recita: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.”
Forse dovremmo considerare una maggiore protezione degli spazi storici senza dare per scontato un Patrimonio irripetibile che rappresenta le nostre radici culturali. Personalmente mi si spezza il cuore ogni volta che vedo graffiti su edifici storici.